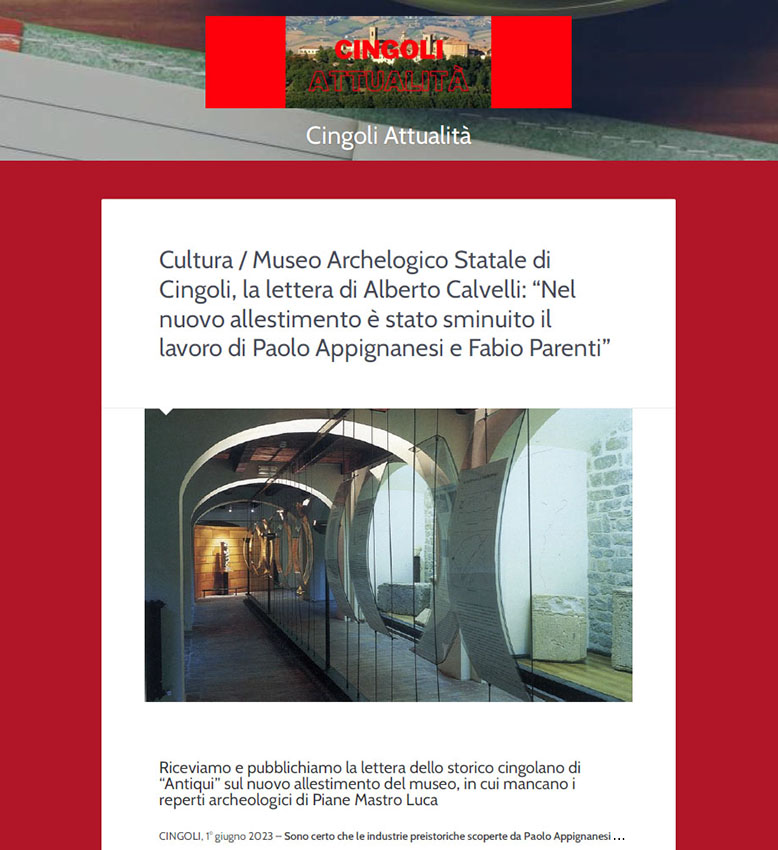|
A partire dal 1968 alcuni appassionati locali, coordinati da Paolo Appignanesi, raccolsero numerosi reperti che furono conservati in un locale al piano terra del Palazzo comunale, messo a disposizione dall'amministrazione comunale con il permesso della Soprintendenza Archeologica, locale che da lì a poco divenne la sede del Museo archeologico. Nel 1973, infatti, fu allestito il Museo civico con reperti prevalentemente preistorici ed una serie di epigrafi romane che erano conservate nel corridoio d’ingresso del Palazzo stesso. Nei primi anni ’80 alcuni saggi stratigrafici condotti dalla Soprintendenza Archeologica delle Marche a Piano di Fonte Marcosa, presso la frazione di Moscosi, accertarono la notevole importanza del sito che restituiva materiali dell’età del Bronzo, del Ferro e dell’epoca romana. La prevista realizzazione dell’invaso di Castreccioni, che avrebbe completamente sommerso l’intera area, spinse le autorità competenti a nuovi interventi di tutela, oltre al vincolo imposto secondo la legge 1089/39. Grazie alla legge 67/88 fu possibile accedere a nuovi finanziamenti che portarono all’elaborazione di un progetto che prevedeva una serie di campagne di scavo e l’allestimento di un museo con i reperti recuperati. Si stipulò quindi un accordo fra il Comune di Cingoli che metteva a disposizione, oltre alle sale del Museo Civico, un seminterrato ed altri locali del piano terra del Palazzo Comunale, e il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali che istituiva con decreto il Museo Archeologico Statale. Nel 1994 si aprì al pubblico l’esposizione relativa ai materiali provenienti dagli scavi di Piano di Fonte Marcosa mentre nel 1997 fu inaugurato il Museo Archeologico Statale. Le raccolte di superficie dei materiali archeologici furono condotte da Paolo Appignanesi (1943-2021), direttore della Biblioteca comunale e delle altre istituzione culturali di Cingoli nonché Ispettore onorario della Soprintendenza Archeologica, ed altri appassionati locali che fecero confluire nei depositi del museo, nel corso di quarant'anni di attività, moltissimi reperti archeologici. "E' doveroso ricordare i nomi di questi disinteressati e generosi collaboratori, i risultati delle ricerche dei quali consentirono l'istituzione del museo archeologico: Bacci Tommaso, Becerica Carlo, Borgoforte Gradassi Antonio, Calvelli Alberto, Cardella Leonardo, Cavalletti Andrea, Colocci Filippo, Gagliardini Ubaldo, Galanti Filippo, Mazzuferi Emidio e Paolo, Mosca Alessandro, Mosca Andrea, Paparelli Vittorio, Pennacchioni Giampaolo e Massimo, Pergoli Pericle, Puccitelli Mauro, Rossetti Roberto, Tosti Liberto e Luigi" (F. Pagnanelli, Una regina e una città senza nome: la civitas di San Vittore di Cingoli, Cingoli 2018, p. 26). Gli spazi espositivi del museo interessano due piani per un totale di circa 300 mq; nel piano seminterrato, un unico locale suddiviso da archi con copertura a volta in mattoni e muratura in blocchi di pietra, sono esposti i materiali provenienti dal sito di Fonte Marcosa, mentre nel piano superiore, il piano terra del Palazzo Comunale, sono collocati i materiali di epoca preistorica, protostorica e romana. Nelle sale è stato allestito un apparato didascalico che fornisce sia delle indicazioni basilari a corredo degli oggetti esposti e sia delle notizie più approfondite inerenti il periodo cronologico, il rapporto territorio-sito-oggetto rinvenuto, la distribuzione dei siti. Dal punto di vista cronologico il percorso espositivo inizia dai materiali del Paleolitico inferiore provenienti da Piane Mastro Luca e Madonna del Pian de’ Conti; strumenti su ciottolo (choppers) associati a schegge ritoccate attestano una frequentazione di queste aree già a partire dalla fine del Paleolitico inferiore arcaico. Interessante, dal punto di vista didattico, è la presenza, accanto a questi manufatti, di arnioni, cioè di grandi blocchi di selce impiegati per la realizzazione degli strumenti. Più consistenti sono a Cingoli le testimonianze del Paleolitico medio, generalmente riferibili al Musteriano; nelle vetrine del museo sono esposti solo alcuni dei tipi più rappresentativi: punte levallois, raschiatoi, nuclei, denticolati e grattatoi. Per il Paleolitico superiore figurano reperti provenienti dallo scavo di Rio-Madonna dell’Ospedale, un sito all’aperto di notevoli dimensioni che ha restituito numerosi strumenti litici riferibili all’Epigravettiano antico a cran.
ll materiale riferibile al Neolitico, ben rappresentato nel territorio cingolano, proviene quasi esclusivamente dalle aree poste nei pressi dei fiumi Musone e Rudielle. Trattandosi anche in questo caso di materiale recuperato in superficie non è stato sempre possibile determinare con esattezza la fase cronologica e culturale di appartenenza anche per la totale assenza di reperti ceramici associati ai manufatti litici. Oltre ai manufatti in selce, come ad esempio punte di freccia, peduncolati e foliati bifacciali, sono presenti gli strumenti tipici della tessitura (navette, fuseruole e pesi da telaio). Lame di ossidiana proveniente dall’isola di Lipari e manufatti di pietra verde, tipica delle aree alpine, testimoniano rapporti commerciali anche con aree piuttosto lontane. Scarsamente rappresentato è invece l’Eneolitico; ad eccezione di asce-martello forate, anche in pietra verde, e foliati a ritocco piatto il territorio cingolano non ha restituito materiale inerente questa fase. Per l’ età del Bronzo, attestato in numerosi siti e fin dalla sua fase più antica, la documentazione più importante ed imponente è fornita dal sito di Piano di Fonte Marcosa. Gli scavi condotti nell’area dal 1986 al 2001 hanno permesso di individuare numerosi livelli di frequentazione databili dal Bronzo medio a quello finale, livelli del VI-V sec. a.C., un sito produttivo di età repubblicana ed una villa romana di età imperiale.
Al Bronzo medio finale sono riferibili due fasi attribuibili alla cultura appenninica con ricche tipologie ceramiche, spesso decorate; la fase iniziale dell’Appenninico è rappresentata da frammenti di ciotole con carena bassa, anse ad apici revoluti tipo S. Paolina di Filottrano, ed anse ad ascia. Il passaggio ad una fase finale dell’Appenninico è testimoniato dalla comparsa dei decori lineari a meandro retto, dai motivi angolari ad excisione sull’orlo del vaso, dalle tipologie delle anse a nastro ed infine dalla presenza di anse con sopraelevazione cilindro retta e a corna di lumaca. La fase iniziale del Bronzo recente ha restituito abbondante materiale ceramico, manufatti di osso, di corno di cervo e di bronzo che attestano l’inizio dell’attività artigianale in loco. A questa fase appartiene anche una struttura lignea (al Museo è stata esposta una piccola porzione) costituita da un tavolato modulare di assi disposte ad incastro su un’intelaiatura di tronchi di quercia e di frassino realizzata a pochi metri dall’antica sponda del fiume. La ceramica d’impasto più depurata è attestata da ciotole carenate, prevalentemente a carena bassa, con anse a sopraelevazione cilindro-rette e cornute. Fra le nuove tipologie sono presenti le scodelle con orlo piatto su cui sono impostate prese triangolari (già attestate a Conelle di Arcevia, Pianello di Genga, Cortine di Fabriano) e le scodelle ad orlo rientrante a superficie liscia. La ceramica d’impasto più grossolana è invece attestata da dolii con orlo a tesa e pareti decorati con cordoni lisci intersecanti a croce, olle con cordoni lisci o decorati da impressioni a ditate o a tacche, scodelloni con cordone liscio ondulato, piatti a basse pareti. Tra gli oggetti di bronzo figurano: ascia ad aletta, spilloni con testa a riccio, con testa quadrangolare e con perforazione ad asola tipo Boccatura del Mincio. Abbondantissima è l’industria su corno di cervo (vanghette, zappette e vomeri di aratro) e quella di osso (manici di lesina con le caratteristiche decorazioni a cerchielli incisi e gambo con espansione a losanga e testa a clessidra, spilloni a rotella con sei raggi e pendagli). Sicuramente, il dato più importante è rappresentato dalla lavorazione in loco del bronzo, testimoniata, fra l’altro da una forma di fusione in arenaria, oltre che da abbondanti reperti come pugnali a codolo (tipo Torre Castelluccia e tipo S. Agata) e a lingua di presa (tipo Pertosa e tipo Bertarina), fibule (tipo Peschiera), spilloni e attrezzi da lavoro (sgorbie per la lavorazione del corno). Sono anche presenti oggetti realizzati in osso, frammenti di fornelli del tipo circolare con fori e le caratteristiche figurine fittili di animali. All’età del Ferro è dedicata una parte del piano terra del Museo dove all’interno delle vetrine sono esposti reperti attribuibili al VI sec. a.C.; tra essi figurano una fibula tipo San Ginesio, una fibula con arco globulare fiancheggiato da risega e decorato alla sommità da castone, un frammento di vaso ingubbiato di nero con una rara decorazione di tipo geometrico ad excisione ed incisione, una fibula a collo d’oca, uno scodellone di impasto, un’olla globulare ad impasto rossastro. Alla fine del VI sec. a.C. appartengono materiali che in alcuni casi dimostrano come anche il territorio cingolano fu interessato dallo sviluppo di insediamenti lungo le principali direttrici commerciali che mettevano in collegamento gli scali adriatici con l’entroterra. E’ il caso di una lekythos miniaturistica a figure nere con Dioniso seduto di fronte a satiri danzanti rinvenuta a S.Vittore. Allo stesso periodo risalgono i tegoloni che dimostrano la presenza di strutture abitative con copertura in cotto e l’unico complesso tombale rinvenuto a Cingoli. Il corredo della tomba, databile fra il 520 e il 480 a.C. comprende una fibula con arco a gomito, una brocchetta in lamina bronzea con corpo troncoconico allungato, una bacinella di bronzo e uno scodellone fittile. Al V-IV sec. a.C. si riferiscono i materiali che provengono quasi esclusivamente da siti posti lungo la vallata del fiume Musone: frammenti di ceramica a vernice nera, ceramica grigia, coppette, mortai, ceramica alto-adriatica. A questa fase appartengono anche le importanti testimonianze del centro santuariale di S. Vittore, un complesso termale collegato ad una sorgente di acqua con proprietà medicamentose. Tra i materiali esposti si segnalano: protomi fittili di una divinità femminile con polos, la porzione di un cratere a campana di ceramica attica a figure rosse, un cratere miniaturistico a calice, pesi da telaio in argilla, ceramica di produzione locale, ceramica a vernice nera, alto-adriatica e ceramica tornita grigio cenere, una statuetta femminile panneggiata, un cratere a calice riferibile ad ambiente etrusco-laziale, ex-voto in forma di busto femminile in terracotta. L’epoca romana è rappresentata dai materiali provenienti dall’area di Borgo San Lorenzo, dove sorgeva Cingulum, da S. Vittore, che gli studiosi identificano con il municipium di Planina, da Pian della Pieve, un centro vicano di notevole importanza, e dalle numerose ville rustiche sparse per il territorio cingolano. Da segnalare la presenza dei corredi di due delle sei tombe ad incinerazione rinvenute a S. Vittore e databili al I sec. a.C. Della tomba n. 1 sono esposti degli oggetti in bronzo pertinenti ad un cofanetto, pedine ed oggetti di osso, vasi di vetro (balsamari, simpulum, bottiglie). Della tomba n. 5 sono esposti vasi di vetro (coppette, olletta, brocche), elementi di bronzo di un cofanetto, un pendaglio in bronzo e pasta vitrea, oggetti in osso, pedine in pasta vitrea, elementi figurati in osso, uno specchio in bronzo rivestito d’argento. Tra gli altri reperti esposti, tipici dell’età repubblicana ed imperiale e provenienti soprattutto dalla zona di S. Vittore, figurano 12 iscrizioni lapidee di età imperiale (pertinenti al municipio di Cingulum ed una proveniente da S. Vittore), 27 monete, coniate in bronzo e argento che coprono un arco cronologico compreso fra il III sec. a.C. e il IV sec. d.C., ed alcune sculture, fra le quali un’ eccellente statua di Attis ed un ritratto di Agrippina Minore.
Con il nuovo allestimento museale, eseguito nel 2022, si è deciso di togliere dall'esposizione i numerosi strumenti su ciottolo del sito di Piane Mastro Luca, una decisione che non è stata motivata dal punto di vista scientifico e che non è stata capita e accettata da tutti coloro, cingolani e non, studiosi e appassionati, che hanno sempre considerato quei reperti come un'importante testimonianza dal grande valore scientifico. Purtroppo, i personalismi, l'incompetenza e le invidie hanno spesso un peso maggiore della ricerca e della riconoscenza.
Rassegna stampa
|