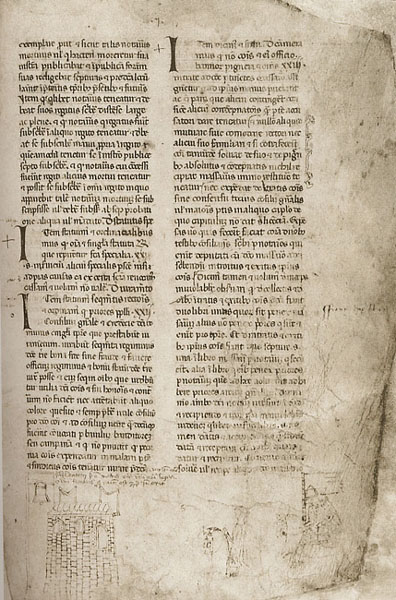|
Al 1307 risale il più antico
testo statutario di Cingoli
(1), composto da un gruppo di 52 capitoli
relativi al diritto pubblico. Il Colini Baldeschi
(2) ipotizza che non
rappresenti, in assoluto, il più antico statuto cingolano. In un
documento pubblicato dallo Zonghi
(3) si apprende, infatti, che nel 1246
il Sindaco del comune di Fabriano ed alcuni nobili della città
convengono che nello statuto da compilarsi siano inserite delle norme
inserite in merito all’affrancazione dei servi servando modum
terrae Cinguli. Sempre secondo il Colini
Baldeschi, questo statuto non sarebbe una vera e propria redazione
statutaria completa ma una serie di capitoli emanati per regolamentare
un settore della vita pubblica cittadina. Nello stesso testo del 1307 si
fa più volte riferimento ad altri preesistenti ordinamenti e
costituzioni: poena in capitulis, statutis et ordinamentis Communis
Cinguli sive nostris constitutionibus contenta (capitolo 12 dello
statuto). Il testo costituisce
un’importante fonte sull’organizzazione costituzionale del Comune
agli inizi del XIV secolo. L’organizzazione comunale era incentrata su
500 Iurati de populo, rappresentanti di tutta la classe popolare
e riuniti nel Parlamento. A capo dell’amministrazione del Comune si
mise un Podestà, funzionario preferibilmente forestiero in carica per
sei mesi, che aveva come collaboratori un vicario, un giudice, due notai
e dieci famigli armati. Il potere legislativo era
prerogativa dei Viginti de populo, una sorta di esperti (sapientes)
che eleggeva l’organo deliberativo, il Consciliariorum populi. Il
Consiglio del popolo era composto da 120 membri rappresentanti i cinque
quartieri cittadini
(4); questo organo veniva convocato
mensilmente nella chiesa maggiore (Pieve di Santa Maria) per deliberare
sui provvedimenti da prendere su proposta del Podestà. Il Consiglio del popolo eleggeva
i Decem de populo che restavano in carica per un mese. I “dieci
di popolo”, oltre ad affiancare il Podestà nella conduzione
dell’esecutivo, nominavano gli ambasciatori e gli altri ufficiali del
Comune. La nuova organizzazione comunale apportava una serie di modifiche alle precedenti normative in modo da scongiurare l’eventualità di ulteriori tentativi da parte di famiglie locali di impossessarsi del potere cittadino (5). Si predisposero così una serie di norme che isolavano socialmente i nobili ed attribuivano ai “giurati di popolo”, appositamente armati, anche le funzioni di milizia (6).
Lo statuto comunale del 1325
viene considerato come uno dei più antichi testi statutari completi del
maceratese e forse della Marca. E’ composto da cinque libri che al di
fuori del secondo e del terzo, rispettivamente de civilibus
quaestionibus e de maleficiis, non hanno una specifica
titolazione. Nello statuto, anche se non mancano disposizioni a sfavore
della nobiltà, non si nota tuttavia quello spirito antimagnatizio che
caratterizzano le disposizioni emanate nel 1307. Il primo libro, composto da 43 rubriche, tratta dell’organizzazione costituzionale e amministrativa del Comune e dei suoi rapporti con il culto e la venerazione dei due patroni principali (S. Esuperanzio e S. Sperandia). Il secondo libro (37 rubriche) tratta del diritto e della procedura civile mentre il terzo (83 rubriche) del diritto e della procedura criminale. Il quarto libro (42 rubriche) tratta in genere delle foreste, dei pascoli, del danno dato. Infine, il quinto libro (71 rubriche) affronta argomenti relativi a viabilità, acque, commercio, tasse, agricoltura, sanità, igiene, ecc. L’organizzazione comunale si
basava, oltre che sul Podestà, su tre organi collegiali: il Consiglio
generale, i Priori, il Consiglio di Credenza. Lo statuto del 1364 è diviso in
quattro libri privi di intitolazione e dell’indice delle rubriche. I
primi tre libri contengono, rispettivamente, norme relative al diritto
pubblico, al diritto e alla procedura civile, al diritto e alla
procedura penale. Il quarto libro contiene disposizioni relative
all’agricoltura, al commercio, all’economia, all’igiene, ecc. Un
quinto libro venne aggiunto nella copia del 1531. Lo statuto manifesta un profondo
ossequio e una grande devozione non solo alla Chiesa e al Papa ma anche
al Legato e a tutti i funzionari della Curia rettorale rispecchiando in
pieno il momento storico della sua formazione. L’altra caratteristica
di questo statuto è la sua lunga vitalità: ancora nel 1797, compilando
l’inventario dell’archivio comunale di Cingoli, il Vogel, a
proposito di questo codice dice: “Statuto del 1364 approvato dal
cardinal Egidio Albornoz, il quale si osserva ancora”. L’organizzazione comunale si
basava sugli stessi organi collegiali definiti nello statuto del 1325.
Il Consiglio generale era composto da 60 membri sufficientes, discretos
et legales; di essi, 45 dovevano essere scelti fra gli abitanti di
Cingoli mentre gli altri 15 dal restante territorio. Per la regolarità
delle sedute era necessaria la presenza dei due terzi dei consiglieri,
che avevano l’obbligo di intervenire (e pene severe colpivano coloro
che entro i tre giorni successivi non avessero giustificato
l’assenza); le delibere, per essere approvate, dovevano ricevere i due
terzi dei voti validi. Sempre lo stesso collegio doveva
poi, fra i 60 consiglieri, scegliere 30 idoneiores et sufficientiores
per ricoprire l’incarico di Priori. I trenta eletti venivano ripartiti
in sei gruppi di cinque membri ognuno che, a turno, di bimestre in
bimestre, ed in base a sorteggio, esercitavano le funzioni priorati. I
Priori operano in stretta unione con il Podestà: fissavano l’ordine
del giorno delle riunioni del Consiglio; davano esecuzione agli ordini
impartiti dal Rettore della Marca; nominavano, insieme al Consiglio, i
vari funzionari comunali. Dovevano abitare nel palazzo comunale e
ricevevano uno stipendio di quattro lire al mese Dallo stesso gruppo dei 30 Priori
il Consiglio generale doveva sorteggiare 15 membri (quindecim de
Credentia), abitanti di Cingoli, che entravano a far parte del
Consiglio di Credenza. Nessun nobile poteva essere eletto Priore o far
parte del Consiglio di Credenza; poiché nessuna norma dice qualcosa in
proposito è lecito pensare che, al contrario, potessero far parte del
Consiglio generale. Al Camerlengo (o Camerario)
faceva capo tutta l’amministrazione finanziaria e nel suo lavoro era
affiancato da due notai nominati dal Podestà e dai Priori. Altri uffici
del Comune erano ricoperti da notai: il Notaio delle riformanze; il
Notaio della custodia che doveva presiedere giorno e notte alla custodia
delle porte del territorio comunale; un notaio addetto al catasto; un
notaio era titolare dell’ufficio del danno dato. Il Sindaco del Comune, eletto dal
Consiglio generale, dai Priori e dal Podestà, spettava la tutela degli
interessi della collettività sia all’interno che all’esterno.
Accanto ad esso c’erano anche i Sindaci delle contrade: uno o più per
contrada, duravano un anno, e loro compito era quello di riferire agli
organi comunali quanto avveniva nelle rispettive zone. Altri funzionari del Comune erano
i Baiuli (o Balivi), che in numero di 6, uno del capoluogo e cinque
delle varie ville, dovevano fare citationes ed altri atti
esecutivi come pignoramenti, sequestri, ecc. sia per conto del Comune
che di terzi; i Banditori, in numero di 2, ai quali spettava annunciare
pubblicamente le disposizioni del Comune o della Curia della Marca. In
caso di necessità il Consiglio generale poteva inviare Ambasciatori al
Pontefice o ad altre autorità per conto del Comune. La norma 26 del I libro dispone, ai fini di una migliore riscossione delle tasse, la suddivisione del territorio cingolano nei tre terzieri di S. Maria, S. Nicola e S. Giovanni dei quali delimita i confini e che divide in contrade.
Breve esposizione di alcune norme dello statuto comunale del 1364
Diritto
e procedura penale (III libro) Tutte le pene sancite dallo
statuto per i vari reati avevano in genere carattere pecuniario: anche i
reati più gravi come la congiura contro il Comune non comportavano pene
detentive. Per i reati più gravi la competenza del giudizio spettava
alla Curia generale della Marca che giudicava secondo le norme delle
Costituzioni Egiziane. Per l’omicidio lo statuto
dispone la cattura dell’omicida da parte degli uomini della contrada
dove è stato commesso. La bestemmia contro Dio era
punita con 25 lire; i bestemmiatori che non avessero pagato la multa
venivano pubblicamente fustigati per le strade di Cingoli. La congiura contro il Comune o la
Chiesa veniva condannata con una multa di 100 fiorini d’oro e la
totale distruzione della casa dove vi era stato organizzato il
complotto. Per il danneggiamento dello
statuto, oltre alla multa di 50 fiorini, la figura dell’autore veniva
dipinta, a perpetua infamia, sulle mura del palazzo comunale (pingatur
in palatio). Altri reati puniti erano
l’aggressione e la percossa con armi o senza, le minacce a mano
armata, le ingiurie (come il dire “falsus, proditor, patarinus,
hereticus, cornutus”), l’incendio e l’usura. Viene punito il furto, la
violazione di domicilio, il chiedere il pagamento di un debito già
estinto, impedire il corso delle acque, andare a caccia di notte,
catturare i colombi, lavorare oltre i confini del comune. Nulla ars,
infatti, poteva essere esercitata al di fuori del territorio comunale,
fatta eccezione per l’agricoltura e per i vasai (figulatorum) e
nessuno poteva esportare vino, olio formaggio e animali di ogni genere. Era proibito portare armi, anche
di difesa, sia di giorno che di notte, soprattutto dentro il palazzo del
Comune, sulla piazza grande e durante le fiere, ad eccezione degli
addetti all’ordine pubblico o per chi si reca fuori dal Comune o ne fa
ritorno. Era proibito ospitare o aiutare i
banditi; vendere terreni o altri immobili ai forestieri, in particolare
a feudatari o a città e comuni; andare di notte per le strade. Vi era,
inoltre, il divieto di giocare d’azzardo e quello di mostrare
incomposte manifestazioni di dolore durante il corteo funebre.
Disposizioni
generali (IV libro) Venivano considerati cittadini di
Cingoli i possessori di immobili che abitino nel comune da almeno un
anno. Il Comune dava in appalto il
taglio dei prati, dei canneti, dei salici e degli altri alberi posti
lungo le “rote” del fiume Musone, il taglio della legna in alcune
zone del territorio, la raccolta dello scotano (per la concia delle
pelli), la raccolta della feccia del vino e la raccolta degli stracci
(per fabbricare la carta). Per i pesi e le misure si
dovevano rispettare quelle imposte dal Comune (il fiorino doveva avere
il peso di quello anconetano, il passo per le stoffe doveva essere come
quello infisso in cippo palatii; la stessa cosa per le altre
misure il cui prototipo si trovava presso il Comune. Due “coppe”
costituivano una “rasenga”, quattro una “salma”; il “rubbo”
si divideva in sei “parti” o “pese”.). Il mercato settimanale delle
merci si teneva il sabato nella piazza grande; quello del bestiame la
domenica. In occasione del mercato settimanale era proibito acquistare
merci o bestiame in luogo diverso dove si svolgeva il mercato. Gli osti dovevano munirsi di
apposita licenza e usare regolari misure (“pititto”, “mezzo
pititto” e la “foglietta” pari ad un quarto di “pititto”)
mentre le venditrici di formaggio, uova, pollame, frutta e verdura (malvendulae)
non potevano acquistare la loro merce per poi venderla prima dell’ora
di terza. I fornai dovevano vendere il pane bene coctum et bene
fermentatum. I macellai dovevano avere carni buone e abbondanti
(naturalmente bollate dal Comune con cera di diverso colore a seconda
della qualità). Era proibito vendere in città carni di animali
ammalati, cosa invece lecita extra terram, presso una delle porte
di Cingoli. Era proibito tenere vuoti gli
spazi destinati alla costruzione delle case, pena la vendita forzata del
terreno; per ragioni di sicurezza, la casa non poteva essere ad una
distanza inferiore a 5 canne dalle mura del comune. Le strade dovevano essere
mantenute nella loro larghezze minime di 15, 8 e 5 piedi a seconda che
fossero strade, vie urbane e vie vicinali. Era proibito gettarvi
immondizie o farvi lavori particolari. I pozzi e le fonti cittadine
dovevano essere tenuti puliti con divieto di facere turpitudinem
nei loro paraggi. Gli animali, specialmente i maiali, dovevano essere
custoditi perché non andassero vagando per il comune sine anulo in
grugno.
Tratto da: Pio Cartechini, Aspetti della legislazione statutaria cingolana nei secoli XIV-XVI, in AA.VV., Cingoli dalle origini al sec. XVI. Contributi e ricerche, Atti del XIX Convegno di Studi Maceratesi, Cingoli 15-16 ottobre 1983, "Studi Maceratesi", 19, Macerata 1986, pp. 361-405
(1) Del Comune di Cingoli ci sono
pervenute due redazioni statutarie complete, una del 1325 e
l’altra del 1364. Accanto ad esse ci sono altri gruppi relativi
al diritto pubblico e a particolari settori come le foreste, il
Monte di Pietà, il danno dato, ecc. dal sec. XIV in poi.
Parte di questa produzione fu
individuata alla fine del XVIII secolo dal Vogel, nel corso del
riordinamento dell’archivio di Cingoli, in diverse pergamene e
codici che erano stati raccolti senza alcun ordine cronologico. Macerata, Archivio Storico, Archivio di Cingoli
L. Colini Baldeschi, Statuti
del Comune di Cingoli, Cingoli 1904, vol. II
P. Colliva, Il Cardinale
Albornoz, lo Stato della Chiesa e le Costituzioni egiziane,
Bologna 1977 C. Manfroni, Gli statuti del Comune di Cingoli, in “Atti e Memorie dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova”. N.S., vol. XXIII (1906-1907), pp. 255-261
(2) L. Colini Baldeschi, Statuti
del Comune di Cingoli, Cingoli 1904, vol. II, p. 10 e segg.
(3) A. Zonghi, Carte
diplomatiche fabrianesi raccolte e ordinate, in C. Ciavarini, Collezione
di documenti antichi inediti o editi rari delle città e terre
marchigiane, vol. II, Ancona 1872, p. 161
(4) Avenani (Avenale), Stratae
(Strada), Trevidiani (Troviggiano), Castri
(Cingoli), Forensium (territorio montano)
(5) Alla fine del XII secolo
Cingoli fu teatro di una delle tante sommosse che aveva visto la
famiglia Mainetti protagonista di un tentativo di presa del potere
che coinvolse le autorità comunali. (6) Al suono della campana o in caso di “rumore” devono correre al palazzo comunale armati di tutto punto: capitolo 2
|