|

|
L'albero
genealogico che qui si presenta è tratto dall'opera Famiglie
celebri d'Italia (1819-1883). L'opera, composta da 184 fascicoli
riuniti in 16 volumi, venne iniziata da Pompeo Litta che pubblicò i
primi 113 fascicoli. Morto nel 1852 il lavoro venne continuato da
altri studiosi: F. Oderici, L. Passerini, F. Stefani di Mauro di
Polvica e da C. Coda.
L'albero
genealogico dei Cima, composto da due tavole, è contenuto nel
volume 12 e contrassegnato con il numero 119.
Oltre
a Pompeo Litta, Famiglie celebri d'Italia, 1819-1883 si veda
anche Luigi Passerini Orsini de' Conti Rilli, Famiglie celebri
italiane, Francesco Basadonna, Milano 1873 |
|
|
|
Dell'Arme
Una
pietra del palazzo pretorio di Firenze ci dà lo stemma
dei Cima quale ve lo lasciò Masio di Tanarello; gli atti
dei nostri podestà ce lo rappresentano coi suoi colori, perché
era uso tra noi che sui libri dei rettori fosse
rappresentato a colori lo stemma del magistrato a cui si
riferivano (Luigi Passerini)
|
|
|
|
|
|
Albero
genealogico - Tavola I |
|
1 -
Attone |
Non ho invero
documento alcuno che mi accerti dell'esser suo oltre a quello che
concerne Revertade suo pronipote, e gli dò posto nella presente
genealogia perchè tutti, anche i più antichi scrittori dei Cima,
lo fanno il progenitore della famiglia; e può d'altronde ben darsi
ch'essi abbiano visti dei documenti che non sono fino a noi
pervenuti. Credesi gli derivasse il cognome da un castello dai suoi
maggiori dominato, distrutto dai venturieri normanni intorno al
1030; castello appellato Cyma, e che dall'y greco
trovasi letto simultaneamente e Cuma e Cima secondo il
modo con cui pronunziavasi; ma che avendo nell'idioma latino
soltanto la desinenza plurale, diè ai suoi possessori il predicato
di de Cymis o de Cumis. Atterrato l'avito castello che
sorgeva appunto ove sorge Monte S.Pietro, i suoi signori si
portarono ad abitare in altro luogo assai forte non molto lontano da
quello chiamato lo Staffolo; da cui poi si ridussero in Cingoli
quando i nascenti Comuni fecero guerra ai baroni del loro contado,
obbligandoli a stabilirsi entro le mura della città. La famiglia di
Attone era assai ramificata ai suoi giorni, e non poche case vantano
con essa consorteria; sembra ancora ch'ei fosse di non piccola
potenza, e che, oltre lo Staffolo, avesse a sè sottoposti Arcione,
Cervidone, Castelsafrano, Colognola, Castelsantangiolo, Castiglione,
Montefreddo, Castelveterno, Castelroberto e Tavignano. E aggiungerò
che dalla divisione e suddivisione dei feudi che vedesi usata nei
tempi che possiamo raggiungere coi documenti, abbiamo fondato motivo
di asserire che la stirpe dei Cima seguì le leggi dei
Longobardi, e con molta probabilità perchè da quelle nordiche
genti traeva l'origine. |
| 1
- Attone |
| 2 -
Ugone |
| 3 -
Gozzone |
| 2 -
Ugone |
Dalle carte del
monastero di s. Vittore in Arcione risulta apertamente che gli fu
padre un Attone, rammentandovisi tra gli enfiteuti Revertade di
Attone di Ugone di Attone; perciò si ingannano quei che lo
asseriscono nato da un conte Ruggero. Senza ulteriori dubbiezze
precede da lui la genealogia della famiglia. |
|
|
| 3 -
Gozzone |
Potrebbero per avventura
essere una sola persona egli e il fratello perchè il suo nome non
è che una corruzione di quel di Uguccione, il quale a sua volta è
una modificazione di quello di Ugo o Ugone. D'altronde lo colloco
qui perchè così hanno fatto quanti mi hanno preceduto nel dare la
genealogia dei Cima, notando che non lo credo al suo più vero
luogo: essendo difficile di mettere insieme l'albero genealogico di
una famiglia estinta da quattro secoli, le cui memorie per
conseguenza sono perite o disperse.
|
| 3
- Gozzone |
| 4 -
Carbone |
| 5 -
Gozzone |
| 6 -
Adamo |
| 5 -
Gozzone |
Nel giugno del 1155
egli e il fratello Carbone donarono al monastero di s. Vittore di
Cingoli, ove stavano i monaci benedettini, la metà di Arcione,
Castelveterno, Montefreddo e Castelroberto colle loro giurisdizioni;
le chiese di s. Gregorio di Cesa e di s. Salvatore del Piano; i beni
che furono di Ardeado e Singozzo conti, e quelli che avevano
ereditati da Adamo loro germano. Queste donazioni facevansi, siccome
è noto, per difendere sotto le ali della Chiesa quei possessi che
erano minacciati da vicini potenti, fossero pure nascenti Comuni o
altri feudatari; non son certo peraltro che tale fosse il movente
che spinse Gozzone e Carbone a quest'atto. So bensì che per tal
donazione il monastero cominciò ad intitolarsi di s. Vittore in
Arcione; e che i Cima derivanti da Ugone, a cui probabilmente
spettava l'altra metà dei luoghi donati, erano per alcune terre
livellari dei monaci. |
|
|
| 6 - Adamo |
Morto prima del
1155. |
| 5
- Gozzone |
| 7 -
Aiuto |
| 8 -
Benvenuto |
| 7 - Aiuto |
Trovasi rettore e
console di Apiro nel 1230 e capitano delle masnade nel 1244. Era
morto nel 1247. |
|
|
| 8 -
Benvenuto |
Ebbe dominio in
Cervidone castello distrutto dai cingolani nel 1227, ora ridotto a
meschino villaggio con poche case. |
| 9 - Gazzone |
Testimone nel 1247 ad un
atto di compra in cui era contraente Clara d'Ottrano sua agnata. |
| 8
- Benvenuto |
| 10
- Franzone |
| 10 - Franzone |
Morto senza prole nel
1276. |
| 2
- Ugone |
| 11 -
Giovanni |
| 12 -
Compagnone |
| 13 -
Attone |
| 14 -
Bertramo |
| 15 -
Ottrano |
| 12 -
Compagnone |
Fu testimone
all'atto per cui il Comune di Cingoli accettò sotto la sua
protezione lo spedale di Buraco il dì 13 ottobre 1230. Avea
dominio più specialmente nel castello di Tavignano insieme col
fratello Giovanni, per il quale erano enfiteuti del monastero di
san Vittore in Arcione. |
|
|
| 13 -
Attone |
Ritengo ch'egli
sia una stessa persona coll'Attone di Ugolino ch'era uno dei
consoli che reggevano Cingoli con mero e misto impero nel 1198,
alloraquando gli abitanti di Arcione, e con essi Pietro abate di
s. Vittore, assai probabilmente astrettivi colla forza delle armi,
fecero atto di sottomissione al Comune cingolano promettendo di
venire a starsi nella città o nel suo distretto e di non rialzare
giammai le mura e le case distrutte del loro castello natìo. E'
questo il più antico documento in cui si trovi Cingoli
rivendicata a libertà, perciocchè prima di questo tempo
soggiaceva ai vescovi di Osimo non solo nello spirituale ma
benanche nel temporale. Nel 1212 piacque ai cingolani di
modificare alquanto il proprio reggimento ponendo alla testa del
governo un potestà elettivo con le attribuzioni che già erano
proprie dei consoli; nella quale contingenza vuolsi, senza che io
ne abbia certezza, che Attone fosse prescelto al nobile officio,
che già avea esercitato in Osimo dieci anni avanti. Altro
documento lo concerne mostrandocelo di più uomo di condizione
elevata, ed è del dì 13 luglio 1227; nel quale giorno Azzo d'Este
marchese della Marca d'Ancona, alla presenza di lui, in Osimo,
condonò al potestà ed al Comune di Cingoli tutto quello che
avrebbe potuto pretendere per la espugnazione di Civitella e di s.
Vitale, perdonando ancora le offese fatte a sè medesimo, e gli
omicidi, le violenze e i saccheggi commessi nei luoghi occupati.
Erano quelli i tempi nei quali i Comuni tutti, fatti consapevoli
della propria forza e desiderosi di estendere i loro confini, si
facevano guerra ai baroni che più si avvicinavano coi feudi al
loro territorio, e quei due castelli appunto erano caduti in loro
potere con grave danno dei signori che li dominavano, danno che il
marchese volle con quell'atto perdonato. Non so in vero se ancora
Attone avesse avute molestie dai cingolani, certo è che nello
stesso 1227 fu espugnato Cervidone forte castello signoreggiato
dai Cima, e che egli allora trovavasi in Osimo, mentre nella sua
casa di Cingoli aveva stanza il potestà Milano colla sua
curia. Ed anche negli atti successivi che lo risguardano lo si
trova assente da Cingoli; avvegnachè nel 1232 era potestà di
Apiro; e stavasi nel suo castello di Staffolo il dì 8 gennaio
1233 quando fece quietanza al sindaco di Apiro per il feudo
dovutogli per avere tenuta la potesterìa
di quella terra,
consistente in 150 lire ravegnane, ed ancora per una casa che egli
era stata assegnata nella nuova terra in conseguenza di certe
convenzioni fatte con quel Comune. Morì prima del 1242. Sposato
con Amabilia che dicesi figlia ed erede del signore di Apiro, nel
qual caso sarebbe sorella della moglie di Andrea di Ugolino da
Montecchio. Il castello feudale coll'annessa terra era costruito
su di alto monte, e dai ruderi che ne avanzano sembra che fosse di
una certa importanza: ma gli abitanti desiderosi di vivere in
libertà edificarono un nuovo castello fuori del territorio
dell'antico loro feudatario, e ben presto si trovarono in grado di
fargli guerra. Il vecchio Apiro fu da essi distrutto, e la casa
accordata nel nuovo ad Attone può ben essere uno dei patti
stipulati tra i vincitori ed il vinto; tanto più che all'istrumento
del 1233 dovè trovarsi presente ancora Amabilia. |
|
|
| 14 -
Bertramo |
Testimone ad un
istrumento del 1227. |
|
|
| 15 -
Ottrano |
E' tradizione che
sopra di un alto monte situato non lungi da Staffolo edificasse
una terra che, dal possesso avutone dai figli suoi, si disse
latinamente Mons filiorum Octrani, e poi in volgare
Montefilottrano. Quanto è sicuro il dominio che essi ne ebbero,
sicuro è del pari che la terra esisteva prima del 1200; nel quale
anno fu distrutta, rifugiandosi in Osimo i suoi abitanti. può ben
darsi peraltro che allora fosse conosciuta con altro nome, e
che riedificata da Ottrano e dominata dai figli suoi, li storici
l'accennassero, parlandone, col nuove nome, dimenticato
probabilmente l'antico. |
| 15
- Ottrano |
| 16 -
Clara |
| 17 -
Matteo |
| 18 -
Gualtieri |
| 16 - Clara |
Era vedova
non so di chi, quando nel 1247 fece acquisto di alcuni beni. |
|
|
| 17 - Matteo |
Trovasi col
titolo di messere, e probabilmente era cavaliere a spron
d'oro. Il dì 13 gennaio 1247, insieme col fratello, fu presente
ad un istrumento di compera stipulato dalla sorella. |
|
|
| 18 - Gualtieri |
Vivente nel 1247. |
| 13
- Attone |
| 19 -
Attolo |
| 20 -
Revertade |
| 25 -
Compagnone |
| 28 -
Ruggero |
| 26 -
Giacomo |
| 30 -
Rinaldo |
| 29 -
Ramberto |
| 20 -
Revertade |
E' rammentato nei
libri dei censi di s. Vittore d'Arcione, al quale pagava un annuo
canone per i beni che possedeva in Col di Croce. |
|
|
| 25 -
Compagnone |
Fu presente in
Montemilone al trattato di alleanza stipulato dai Comuni di
Camerino, Tolentino, Cingoli, Matelica, Sanginesio, Montemilone e
Montecchio per resistere ai seguaci del partito imperiale il dì
27 marzo 1248. |
|
|
| 28 -
Ruggero |
Morì prima del
1242, e nell'atto unico in cui, già defunto, lo si trovi
rammentato, vedesi distinto colla qualifica di messere (dominus),
da che dovrebbe dedursi che fu giudice o cavaliere. |
|
|
| 26 -
Giacomo |
Quest'uomo
ammogliato e padre viene negli alberi della famiglia notato come
frate minore e vescovo di Fermo: da che si può scorgere qual fede
possa prestarsi alle antiche genealogie. Conosco di lui due
documenti. Il primo del dì 9 luglio 1268, celebrato in Osimo,
porta la restituzione della terza parte del castellare di
Cervidone ch'ei fu costretto a fare a Benvenuto vescovo di quella
città; l'altro del dì 5 settembre 1279 contiene la donazione di
due molini sul Musone fatta a Susanna abbadessa del monastero di
s.a Caterina di Cingoli. La storia poi ci narra come fattosi coi
fratelli sostenitore di parte guelfa contro Federico II e Manfredi
sofferse grandi guasti nei suoi possessi marchigiani, per opera di
Egano maresciallo imperiale nella Marca d'Ancona; il quale nel
1259 prese a forza il castello di Cervidone, e lo distrusse dopo
averlo dato in preda al saccheggio. Rialzata la fortuna dei guelfi
per le vittorie di Benvenuto e di Tagliacozzo, i Cima
riedificarono le mura del diruto palagio e della rocca; e i
cingolani si affrettarono a descriverlo nel loro estimo. Protestò
Giacomo, e con lui il figlio, i fratelli, i nipoti, ma invano:
talmentechè si rese necessario di ricorrere ai tribunali,
pretendendosi dai Cima che la nuova costruzione desse loro diritto
di piena giurisdizione. Continuava la lite nel 1274, e ne ignoro
la decisione.
Sposato con Anna
··· |
|
|
| 30 -
Rinaldo |
Trovasi
qualificato capo del Comune di Cingoli in un atto solenne del dì
7 febbraio 1253, per il quale Giacomo rettore del monastero di
sant'Andrea gli consegnò un breve pontificio, i beni pertinenti
allo spedale dello Spineto: e questo serve a smentire l'asserto di
quei scrittori che lo dissero intorno a quel tempo abate di s.
Vittore in Arcion. E da carte del 1277 relative a s. Vittore si
ritrae che aveva allora signoria in Lombricara e Selvalonga che
per l'alto dominio rilevavano da quel monastero. |
|
|
| 29 -
Ramberto |
Nel 1242, il dì
13 di novembre, a nome proprio, dei fratelli messer Giacomo e
messer Rinaldo, non meno che dei figli del defunto messer Ruggero,
comperò da Ruggero di Arcola il pieno diritto di fabbricare una
chiesa sul torrente Musone, nel luogo detto il varco di Cerro. |
| 20
- Revertade |
| 21 -
Attone |
| 21 -
Attone |
Avea parte di
dominio in Cervidone, in Arcione, nel castellare di Attone di
Bettino e in quel della Rocca presso il fosso dei Paperini e il
Musone; e nonostante, dedicandosi a vita religiosa nel monastero
di s. Vittore in Arcione, volle per umiltà essere converso. |
| 21
- Attone |
| 22 -
Ruggeruccio |
| 23 -
Corrado |
| 24 -
··· |
| 22 -
Ruggeruccio |
E' uno dei Cima
che i Mainetti cacciarono da Cingoli nel 1304 dopo di avere
saccheggiate e distrutte le loro case. |
|
|
| 23 -
Corrado |
Fu testimone ad
un atto rogato il dì 25 maggio 1297 da Andrea notaro della chiesa
di s. Valentino a Marta, con cui Feltranuccio di Monaldo Da
Montecampanario si fece cittadino di Cingoli, obbligandosi ad
atterrare il suo castello di Moscosi. |
|
|
| 24 -
··· |
Sposa di Simone
di Cerlongo. |
| 26
- Giacomo |
| 27 -
Bulgarello |
| 27 - Bulgarello |
Vivente ancora nel
1268 e nel 1274. |
| 30
- Rinaldo |
| 31 -
Baligano |
| 32 -
Taddeo |
| 31 -
Baligano |
Abbenchè in
tutti gli alberi dei Cima si ponga suo padre tra i figli d'Ottrano,
senza che si alleghi documento di sorta per giustificare il nesso
genealogico, io lo pongo invece in questo luogo, perchè ho visto
una carta in cui è qualificato Baliganus Raynaldi Actonis de
Cimis. Era cavaliere dell'aurata milizia.
Sposato con
Bellafiore ··· |
|
|
| 32 -
Taddeo |
E' nominato nella
sentenza proferita dal rettore della Marca contro i Mainetti
nel 1306 per essere espulso a forza da Cingoli da Appigliaterra
quando vi rientrò con i suoi ghibellini. |
| 31
- Baligano |
| 33 -
Rinaldo |
| 33 -
Rinaldo |
Signore del piccolo
castello di Staffolo, non avea certo grandi occupazioni nel
proprio stato, nè doveva piacergli andare a vivere suddito e
privato in qualche città: laonde, imitando l'esempio di molti
signorotti delle Marche e delle Romagne, si diè ad esercitare il
lucroso ed onorifico officio di potestà o capitano nei luoghi
retti a Comune; officio nobile nei suoi primordi, ma che si rese
ridicolo e spregevole quando cominciò a diventare un mestiere.
Rinaldo era già cavaliere a spron d'oro, grado assai
probabilmente conseguito per militari servigi, quando andò potestà a Perugia nel 1322. Tenne lo stesso officio in Firenze per
i primi sei mesi del 1332, e nell'anno appresso, essendo rettore
per la Chiesa in Bologna, dovè prender parte alla guerra che il
legato volle fare contro gli Estensi. Fu potestà in Siena nel
1339, e dallo stesso Comune fu nel 1341 condotto al soldo per far
guerra ai pisani insieme all'esercito fiorentino. Dopo di aver
tenuta la potesterìa di Bologna per una seconda volta nel 1343, la
repubblica fiorentina lo elesse capitano del popolo, difensore
delle arti e conservatore della pace, con straordinaria balìa,
per sei mesi cominciati col dicembre dell'anno istesso; ma non
ebbe occasione di far uso del pieno potere concessogli, perchè la
città, uscita da poco da luttuose vicende, si riposò quieta e
tranquilla. Morì Rinaldo intorno al 1348.
|
| 33
- Rinaldo |
| 34 -
Baligano |
| 35 -
Paolo |
| 36 -
Carlo |
| 37 -
Pietro |
| 34 -
Baligano |
Era cavaliere a
spron d'oro. Fu potestà di Perugia nel 1342. Morì nel 1348. |
|
|
| 35 -
Paolo |
Fu cavaliere a
spron d'oro, e potestà in molti Comuni. Lo ebbe Perugia nel 1362,
Siena nel 1365, Firenze nel 1367, Bologna nel 1370, Todi nel 1373.
Intervenne ad un trattato di alleanza stipulato dai suoi congiunti
con Giovanni Visconti arcivescovo e signore di Milano nel
1351; nel quale volle stipulato che dovesse riconquistarsi e
rendersi ai Cima la signoria di Staffolo di cui eransi
impadroniti i Malatesta. Mandò invero al Visconti quel
piccolo aiuto di genti che avea pattuito; ma le promesse del
prelato svanirono, e forse credè di far gran cosa per lui
facendolo comprendere tra i suoi alleati nell'istrumento di pace
che stipulò coi fiorentini in Sarzana il dì 31 marzo 1353. Nè
miglior ventura ebbe militando coi Malatesta e gli Ordelaffi
contro il cardinale Albornoz legato pontificio in Italia.
Vinto presso Montefiore di Recanati, dovè umiliarsi e chiedere
perdono; e dopo che lo ebbe ottenuto, si schierò sotto le
bandiere della Chiesa, e riuscì finalmente a riavere il suo
castello di Staffolo in benemerenza dei servigi prestati. Passò
gli ultimi anni in quel suo castello, dove fece dono di alcune
reliquie alla chiesa di s. Francesco nel 1370. Morì nel 1375. |
|
|
| 37 -
Pietro |
Stavasi a reggere
il suo feudo di Staffolo durante la vita di suo fratello, il
quale, continuamente occupato in preture, lasciava a lui la somma
delle cose nella piccola signoria. Par probabile che morto Paolo,
continuasse in un sistema che non talentava a Federico suo nipote;
certo è che questi, approfittandosi dello sconvolgimento in cui
trovavasi la Marca d'Ancona nel 1375, invase con armati il
castello, e lui cacciò di seggio usurpandosi la signoria. |
| 38 -
Antonio |
Dopo di aver
lottato inutilmente contro il cugino per riacquistare il castello
di Staffolo che gli aveva usurpato, vedendo impossibile di
vendicarsi da sè medesimo, in specie poi che fu caduto in mano
agli Smeducci cedè le sue ragioni al signore di Cingoli.
N'ebbe in benemerenza l'officio di potestà a vita in quella
città, e lo ritenne infatti fino alla sua morte avvenuta nel 1386. |
| 35
- Paolo |
| 39 -
Federico |
| 40 -
Rinaldo |
| 39 -
Federico |
Facendo suo prò
dei tumulti che agitavano la Marca di Ancona ribellata a Gregorio
XI per opera dei fiorentini, nel 1376, si portò con forte stuolo
di armati al castello di Staffolo e ne cacciò lo zio; per la qual
cosa fu scomunicato da fra Pietro vescovo di Osimo nell'anno
istesso. Ne fu conseguenza una piccola guerra di rappresaglie che
non fu troppo favorevole allo spogliato; ma non ne andò liete
neppure Federico essendosi dovuto assoggettare a cedere
l'acquistato feudo alli Smeducci di Sanseverino, i quali vi
si fecero dichiarare viari pontifici nel 1379. Peraltro in
progresso di tempo recederono dalle loro pretese, e vennero ad
amichevole composizione coi figli di Tanarello. Federico fu in
seguito potestà di Macerata nel 1392, e teneva quell'officio
quando Bonifazio IX accordò a quel Comune il privilegio della
zecca. |
|
|
| 40 -
Rinaldo |
Morto a Todi il
dì 1 agosto 1373, sepolto con monumento nel chiostro attiguo alla
chiesa di s. Fortunato. |
| 28
- Ruggero |
| 41 -
Giovannuccio |
| 42 -
Cimarello |
| 41 -
Giovannuccio |
Nel 1269, il dì
3 di settembre, fu testimone ad un istrumento di procura che le
monache di s.a Caterina di Cingoli fecero per la elezione della
loro badessa. Questo atto ci rivela ch'era già tornato a Cingoli;
ma ben più gravi congetture dobbiamo trarre dal vederlo potestà
in patria con Appigliaterra Mainetti nel 1280. Cingoli, siccome
ogni altra città e terra d'Italia, era divisa dalle sciagurate
fazioni di Chiesa e d'Impero, di guelfi e di ghibellini. Non ci
sono note le vicende luttuose che doverono funestare di stragi e
di esili questa terra al pari delle altre; i successivi
avvenimenti ci fanno conoscere che i Cima erano alla testa
dei guelfi, mentre i Mainetti capitanavano i ghibellini.
L'anno 1280 fu anno di pace nella più gran parte d'Italia, per
opera più specialmente di papa Niccolò III; e pace dovè pure
celebrarsi in Cingoli dove, in segno di perdono scambievole,
sederono insieme nel supremo maestrato i capi delle due già
nemiche fazioni. Giovannuccio fu nell'anno appresso chiamato
potestà loro dai pisani, sottomessi al suo scettro dal guelfo
conte Ugolino Da Donoratico; ed ebbe l'onore consegnare il
suo nome nel libro dei nuovi statuti che s'impose il Comune.
Questi nobili offici sostenuti da lui e dai maggiori, e confortati
dall'appoggio d'irrecusabili documenti, mostrano apertamente con
quanta malafede Orazio Avicenna scrivesse la sua storia di
Cingoli; il quale nell'interesse di esaltare i Silvestri,
che lo pagavano a tale oggetto, depresse i Cima assegnando
ad essi umili e moderni principii, a segno di asserire che Pagnone
figlio di questo Giovannuccio era un notaro meschinello, portato
avanti e iniziato agl'impieghi da Francesco Silvestri
vescovo di Firenze. Sposato con
Verona ··· |
| |
|
|
|
|
41 - Giovannuccio |
|
| 43 -
Ruggero |
|
| 44 -
Ramberto |
|
| 45 -
Masio |
|
| 46 -
Beatrice |
|
| 47 -
Pagnone |
|
| |
|
| 43 -
Ruggero |
Monaco: abate di s. Vittore in
Arcione. |
| |
|
| 44 - Ramberto |
Fu col fratello
Pagnone alla occupazione di Cingoli nel 1308; laonde è rammentato
nella condanna per questi fatti proferita da Martino da Fano
giudice dei malefizi. |
| |
|
| 45 -
Masio |
Sposato con
Contesssa di Traseo |
| |
|
| 46 - Beatrice |
Badessa nel
monastero di s.a Caterina di Cingoli; morta nel febbraio 1340. |
| |
|
| 47 - Pagnone |
Vedi Tavola II |
| |
|
 |
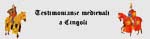 |
 |
| Home
Page Cingoli |
Sommario |
Famiglia
Cima - Tavola II |
|
|